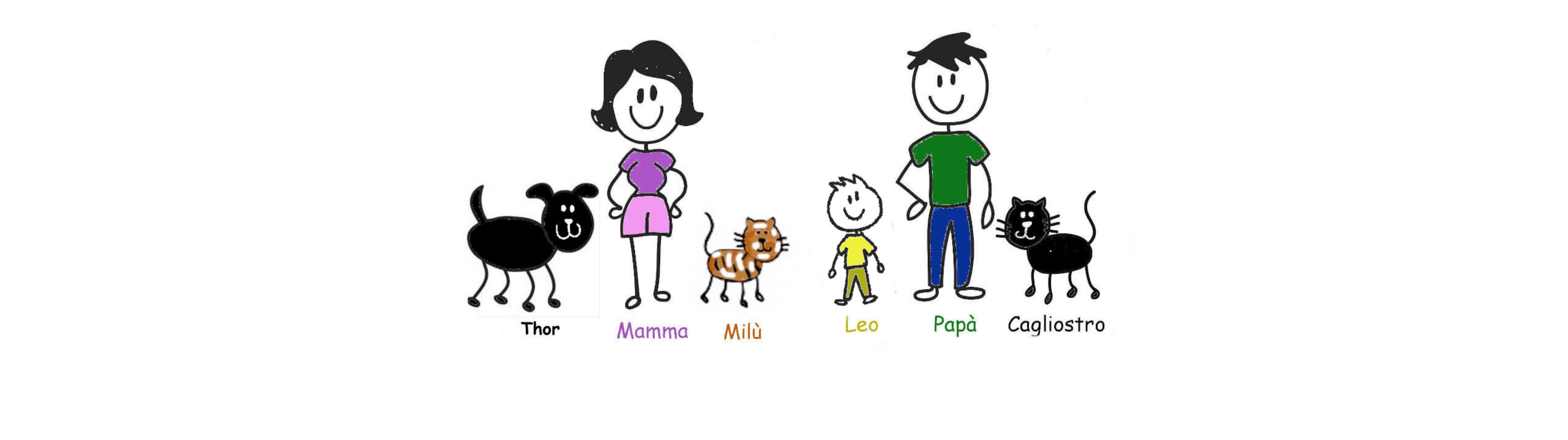C’è stato un tempo in cui avevo un nome… c’è stato un tempo in cui avevo un lavoro… c’è stato un tempo in cui ero un uomo… qualsiasi cosa questo significhi. Poi le cose sono cambiate… La malattia mi ha cambiato.
Sono stato male e sono stato ricoverato in ospedale. Non sto bene, forse non starò bene mai più. Risonanza magnetica… è così che la chiamano. I dottori mi hanno spiegato che questa macchina bombarda il corpo di onde radio e permette una scrupolosa indagine diagnostica. Come sono arrivato qui dentro? Quand’è che la mia vita ha cominciato a finire? Credo che il primo segnale sia stato una leggera influenza. Mi sono prescritto da solo un paio di aspirine e sono andato avanti con la mia vita. Poi è arrivato il tremore alle mani e la debolezza nelle gambe. Ho pensato di aver esagerato con i medicinali e li ho sospesi. A quel punto ho cominciato ad avere problemi alla vista e le vertigini. Mi sentivo malissimo e sarei dovuto andare subito da un dottore, ma le malattie mi spaventano a morte e, come ogni buon ipocondriaco che si rispetti, i dottori mi spaventano ancora di più. Quando vado da un medico ho sempre paura che scopra che sono affetto da qualche male incurabile e mortale. E’ per questo che non ci vado mai, preferisco non sapere.
Sono al Royal Free Hospital, la mia nuova casa. Il professor Faber, un luminare nel campo della medicina diagnostica dice che hanno escluso tutte le patologie mortali conosciute. Dovrebbe essere una buona notizia, ma il fatto che la cosa che mi sta uccidendo non abbia nemmeno un nome non mi è di gran consolazione. Mi hanno messo il lista per un’altra serie di esami, per andare maggiormente a fondo del problema, “chirurgia endoscopica”… insomma si trattava di infilarmi dei tubi dentro al corpo. Sembrano tutte cose dolorose, ma sarebbero state fatte in anestesia locale o generale, come se questo dovesse rassicurarmi: l’unica cosa che mi terrorizza di più di un intervento chirurgico è l’anestesia, è come fare un salto nel vuoto, lontano dalla luce, fin dentro il buio.
Mi risveglio in una stanza fredda e vuota, c’è una vecchia infermiera strana, che mi dice, mentre fuma una sigaretta, di non conoscere nessun dottor Faber. Io mi alzo, sono debolissimo, mi alzo il camice e vedo una lunghissima ferita chiusa alla bell’e meglio, come fossi un maialino ripieno. Svengo.
Mi riprendo, ho la vista annebbiata e vedo un dottore. Non è Faber, dice di chiamarsi Vonnegut e mi chiama “signor Carver”. Io non mi chiamo Carver! Non sono confuso come dicono loro, voglio andarmene da qui, voglio parlare col mio dottore. Arrivano gli inservienti , mi costringono a letto, mi danno un sedativo, dicono che sono sotto shock. Tento di spiegargli chi sono, ma il sedativo fa effetto e perdo nuovamente i sensi.
Ho un incubo tremendo: sono a casa, finalmente, ma l’amico che è con me si trasforma in un mostro e mi dice che Lei mi vuole. Lei chi? “Mater Morbi”. Poi appare un ragazzino, Vincent, sono di nuovo in ospedale. Mi spiega che è normale il fatto che i dottori non mi riconoscano, l’identità è la prima cosa che Lei ti strappa via, poi ti toglie la dignità e alla fine si prende la tua stessa vita. Mi guardo allo specchio, sembro un letto sfatto, ma questo è solamente l’inizio: Lei mi consumerà poco a poco, fino a quando non si sarà stancata di me.
L’ospedale è il luogo dove ci si sente più soli al mondo. Non conta quanta gente possa venire a farti compagnia e a darti il suo sostegno: la distanza che passa tra sani e malati è uno spazio infinito che neanche l’amore può colmare. La malattia mette chi ne viene colpito fuori del consorzio umano. E per quanto amici e parenti possano volerti bene, nella parte più atavica del loro cervello ci sarà sempre un uomo delle caverne ansioso di allontanarsi dall’animale infetto che sei diventato. Del resto, agli occhi di chi sta male, quelli in salute saranno sempre manchevoli, perché incapaci di comprendere il loro bisogno, perché ignari della loro sofferenza e perché colpevoli di potersene andare sulle proprie gambe.
Il malato è un vampiro assetato di vita e poco importa quante lacrime vengono versate per lui… non saranno mai abbastanza da placare la sua sete. La malattia non celebra alcuna comunione. I letti di una stanza d’ospedale sono come le camere di scoppio di un revolver, con i pazienti a fare da proiettili e la guarigione come unico obiettivo…quello che conta è colpire il bersaglio personalmente, perché non c’è alcuna ricompensa nel successo degli altri.
Nessuno è triste nell’abbandonare un ospedale, e quel lieve senso di rammarico per i compagni di sventura lasciati indietro si scioglierà come neve al sole appena tornati in libertà. Qualcuno ha detto che nessun uomo è un’isola, ma sono ragionevolmente certo che a dirlo è stata una persona in buona salute.
(continua domani…)