Il giovane venditore rimase qualche minuto pensieroso.
“Una maestra… addirittura… una maestra… Quando andavo a scuola a Corbesassi avevo un maestro che arrivava da Varzi, o da un paese vicino. Mi sembrava altissimo, intelligentissimo, vecchissimo e soprattutto molto austero e severo. Io, per fortuna, me la cavavo molto bene in aritmetica e quindi riuscivo a scusare qualche carenza nelle altre materie. Non avevo mai conosciuto prima d’ora una maestra, soprattutto una della mia età. Caspita: una maestra, una vera maestra!”.
Fu destato da una mano che si era posata sulla sua spalla: era lei!
“Allora, ci facciamo un ultimo giro? Però devi promettermi che stai più attento e cercherai di non pestarmi troppo i piedi”.
E ballarono, ballarono, ballarono fino al tramonto. Il ragazzo si rese conto che doveva imboccare la via del ritorno, aveva parecchia strada da fare per tornare a casa.
“Il mese prossimo c’è la festa a Vezimo, vieni?” disse la maestrina di Zerba.
“Credo proprio di sì, allora ci vediamo là, così puoi darmi altre lezioni di ballo.”
“Volentieri, mi sei molto simpatico, e pensare che mia mamma mi aveva parlato male di te.”
“Ah si? Posso conoscere il motivo di questa antipatia?”
“Beh, diceva di starti alla larga perché sei un commerciante, e quindi un buono a nulla, uno che non è capace neanche di andar nei campi o curare gli animali, e poi che sei uno sbruffone, un fanfarone. Sai, i miei genitori hanno fatto dei sacrifici per permettermi di studiare e vorrebbero per me qualcuno che abbia un lavoro solido e un avvenire garantito, non un mercante.”
“Aspetta un attimo, non ti sembra di correre un po’ troppo? Abbiamo solo ballato insieme.”
“Hai ragione, scusa” disse lei diventando tutta rossa, e aggiunse: “Allora ci vediamo, ciao”. E corse via, verso casa.

Durante il viaggio di ritorno il ragazzo non fece che pensare a quegli occhi, a quelle parole, i balli di quel pomeriggio, a quella figura minuta, i suoi capelli, le sue mani. Pareva che i propri piedi camminassero da soli lungo il sentiero del Lesima, non sentiva né il freddo né la fatica. Non era preoccupato, ma neanche soddisfatto, di come erano andate le vendite. Non gli importava più, pensava solo a lei, la maestra, la ragazza di Zerba, e quando fu arrivato vicino a casa i suoi pensieri si erano riassunti in una sola, forse avventata, ma solida, convinzione: “Io, un giorno, la sposerò!”
Qui finisce, per noi, questa storia, che è un po’ vera e un po’ narrata sulle ali della fantasia. Non so veramente come siano andate le cose, non so come realmente si siano incontrati, come si siano conosciuti, ma mi piace immaginare che sia andata proprio così, come vi ho raccontato. Quello che so per certo è che la favola del commerciante e della maestra è una bella storia, che è durata tutta la vita. Ancora oggi, che hanno passato gli ottant’anni, quando guardano il monte Lesima, ai cui fianchi sono cresciuti e vissuti, pregano verso la croce che svetta sulla sua cima, e ringraziano il Signore per tutto ciò che gli ha regalato. Come faccio a sapere tutte queste cose? Perché il ragazzo di Ponti e la ragazza di Zerba li conosco molto bene: li vedo tutti i giorni da quando sono nato!
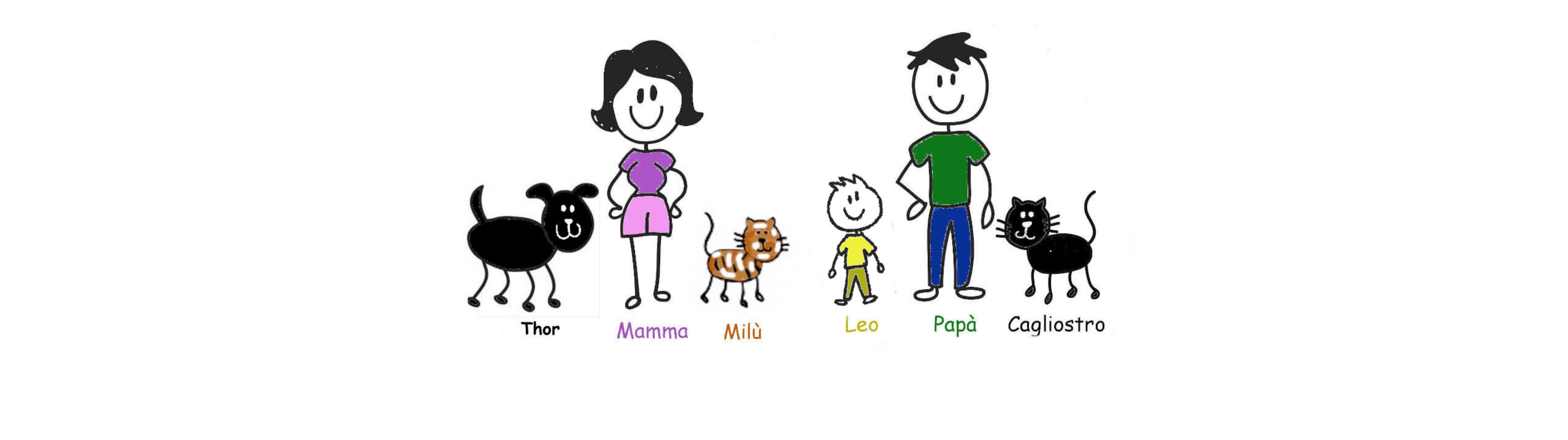




 Verso le tre del mattino, quando ero convinto che non sarebbe accaduto nulla, ricominciarono i rumori provenienti dalla sala. Stavolta uscii subito allo scoperto brandendo il bastone. Il visitatore notturno era lo stesso della notte precedente. Quando mi vide arrivare lasciò cadere la bottiglia di vino che aveva tra le mani e si diresse urlando verso l’uscita sbarrata, che attraversò senza aprire. Rimasi talmente scosso che non potei muovermi, mi ci vollero diversi minuti per riacquistare il sangue freddo. Controllai bene la porta d’entrata che era chiusa a doppia mandata. Non vi erano più dubbi, quell’essere non era reale, vale a dire che non era fatto di materia, insomma non era umano. Mentre ero perso in questi pensieri udii rumori di passi, mi voltai di scatto e lo rividi: era lui, era lì, lui in persona, o in non-persona, e qualunque cosa fosse, era a non più di quattro o cinque metri da me.
Verso le tre del mattino, quando ero convinto che non sarebbe accaduto nulla, ricominciarono i rumori provenienti dalla sala. Stavolta uscii subito allo scoperto brandendo il bastone. Il visitatore notturno era lo stesso della notte precedente. Quando mi vide arrivare lasciò cadere la bottiglia di vino che aveva tra le mani e si diresse urlando verso l’uscita sbarrata, che attraversò senza aprire. Rimasi talmente scosso che non potei muovermi, mi ci vollero diversi minuti per riacquistare il sangue freddo. Controllai bene la porta d’entrata che era chiusa a doppia mandata. Non vi erano più dubbi, quell’essere non era reale, vale a dire che non era fatto di materia, insomma non era umano. Mentre ero perso in questi pensieri udii rumori di passi, mi voltai di scatto e lo rividi: era lui, era lì, lui in persona, o in non-persona, e qualunque cosa fosse, era a non più di quattro o cinque metri da me.

 Questi potrebbero essere tutti i titoli di altrettanti miei racconti di infanzia. In uno delgi ultimi post vi ho parlato del Kursaal, che rappresenta soprattutto le mie estati da quando sono "grande". Questi invece sono tutti racconti di quando ero ragazzino. Scegliamone uno a caso, non posso raccontarveli tutti: R e la tavoletta. Da piccolo avevo un grande amico: R. Viveva ad Abbiategrasso con sua mamma, suo fratello, il compagno di sua mamma e suo figlio. Questi ultimi due l’ho capito solo quando sono diventato un po’ grandicello chi erano, da piccolo ero convinto che fossero suo zio e suo cugino, anche perchè lui stesso li definiva così. Io e R eravamo grandi amici. Lui veniva su a Brallo in tutte le feste e poi d’estate era su da Giugno a Settembre. Aveva un anno in meno di me e quindi io, che ero quello "grande" e inoltre conoscevo i posti, ero quello che "comandava". Cavoli quante cose con R. Quando pioveva passavamo le giornate a casa sua a giocare a Scala 40, ma in tutti gli altri giorni… non ci fermava nessuno, giravamo dappertutto e ne combinavamo di ogni. Poi un anno, quando avevo circa 12 anni, la brutta notizia: la sua famiglia reputava l’affitto troppo caro e quindi dall’anno dopo sarebbero andati in vacanza a Cegni. Pochi chilometri da Brallo, ma per un dodicenne come se fosse un altro pianeta. Ma prima di partire, proprio quell’anno un ente, se non sbaglio la Provincia, aveva organizzato una specie di campus estivo per i ragazzini. Organizzavano giochi, gite e quant’altro. E così io e R siamo finiti in gita alla piscina di Varzi. Era la prima volta che andavo in piscina (e fino all’anno scorso anche unica). Sia io che lui avevamo paura dell’acqua alta. Ad un certo punto io ero fuori e lui mi chiama, tutto contento, per farmi vedere che aveva recuperato una tavoletta, non so dove, e si era avventurato dove non si toccava. Dopo qualche minuto arriva un bagnino, portando R tutto malconcio in braccio: stava affogando e l’aveva preso appena in tempo. Gli organizzatori ovviamente si sono cagati sotto.
Questi potrebbero essere tutti i titoli di altrettanti miei racconti di infanzia. In uno delgi ultimi post vi ho parlato del Kursaal, che rappresenta soprattutto le mie estati da quando sono "grande". Questi invece sono tutti racconti di quando ero ragazzino. Scegliamone uno a caso, non posso raccontarveli tutti: R e la tavoletta. Da piccolo avevo un grande amico: R. Viveva ad Abbiategrasso con sua mamma, suo fratello, il compagno di sua mamma e suo figlio. Questi ultimi due l’ho capito solo quando sono diventato un po’ grandicello chi erano, da piccolo ero convinto che fossero suo zio e suo cugino, anche perchè lui stesso li definiva così. Io e R eravamo grandi amici. Lui veniva su a Brallo in tutte le feste e poi d’estate era su da Giugno a Settembre. Aveva un anno in meno di me e quindi io, che ero quello "grande" e inoltre conoscevo i posti, ero quello che "comandava". Cavoli quante cose con R. Quando pioveva passavamo le giornate a casa sua a giocare a Scala 40, ma in tutti gli altri giorni… non ci fermava nessuno, giravamo dappertutto e ne combinavamo di ogni. Poi un anno, quando avevo circa 12 anni, la brutta notizia: la sua famiglia reputava l’affitto troppo caro e quindi dall’anno dopo sarebbero andati in vacanza a Cegni. Pochi chilometri da Brallo, ma per un dodicenne come se fosse un altro pianeta. Ma prima di partire, proprio quell’anno un ente, se non sbaglio la Provincia, aveva organizzato una specie di campus estivo per i ragazzini. Organizzavano giochi, gite e quant’altro. E così io e R siamo finiti in gita alla piscina di Varzi. Era la prima volta che andavo in piscina (e fino all’anno scorso anche unica). Sia io che lui avevamo paura dell’acqua alta. Ad un certo punto io ero fuori e lui mi chiama, tutto contento, per farmi vedere che aveva recuperato una tavoletta, non so dove, e si era avventurato dove non si toccava. Dopo qualche minuto arriva un bagnino, portando R tutto malconcio in braccio: stava affogando e l’aveva preso appena in tempo. Gli organizzatori ovviamente si sono cagati sotto.